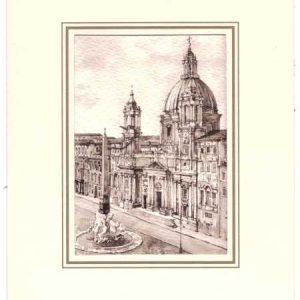Si legga qui la prima parte della recensione.
La complessità dell’intreccio non deve ingannare, ci sono delle costanti nella narrazione che occorre ben riconoscere per comprendere il senso di tutto il romanzo. Intanto, le storie dei due fratellastri sono solo in apparenza analoghe e parallele. Come dimostra la circolarità del testo, se si tiene conto della prossimità tematica tra prologo ed epilogo, è soprattutto la scoperta compiuta da Michel a imprimere alla narrazione l’impronta dell’originalità e, a quanto dice la voce narrante, della verosimiglianza. La scoperta del modo di mutare geneticamente l’umanità mediante la clonazione è infatti la logica conclusione di una narrazione che mette in evidenza il disastro della civiltà occidentale ben rappresentato dalle due biografie di Michel e Bruno. Altrimenti detto, le loro vite rappresentano l’esemplificazione di un tracollo umano che rende necessaria la mutazione metafisica auspicata nel Prologo e ribadita con maggiori particolari nell’Epilogo. Così, se Michel è arido e insensibile, Bruno, l’erotomane, è schiavo delle sue pulsioni sessuali, anche se non riesce a soddisfare veramente una donna. Il primo, arido e vuoto, è indifferente alle profferte amorose di Annabelle, verso la quale riesce a sentire solo compassione; il secondo sa vivere soltanto nell’ambito sfrenato del sesso di gruppo, causando involontariamente la fine della sua partner Christiane (che, si badi bene, sa di essere malata e di rischiare). A ben vedere, entrambi i fratellastri non sono capaci di amare una donna e lo dimostrano con una condotta opposta: Michel sceglie la rinuncia e l’astinenza, Bruno la promiscuità sessuale. Il punto è che questi comportamenti non sono avulsi dalla società, come si evince da molti episodi secondari, ma si innestano in una finta liberazione sessuale che non lascia spezio ai sentimenti. Quanto ai due fratellastri in generale, Bruno è praticamente un fallito, mentre Michel diventa un famoso scienziato. Il punto in comune è qui più arduo da trovare, ma esiste. Consiste nella coscienza dell’impossibilità di amare. Bruno reagisce esaltando la sessualità intesa come surrogato della vita e si rifugia nel razzismo e nel conservatorismo più cieco. Michel, anche lui privo della speranza di una vita per davvero vissuta emozionalmente, sceglie la razionalità del positivismo (Comte) e orienta i suoi studi verso la realizzazione di alcuni aspetti del “Mondo nuovo” di Huxley, come il controllo genetico, ma offrendo all’umanità l’immortalità, che annullerebbe l’invecchiamento e la coscienza della morte. A questo servono la clonazione e la replicazione degli esseri umani. Michel ha compreso che l’esistenza del desiderio, inerente all’essenza umana, è la fonte primaria di infelicità e di odio fra gli uomini; è ineliminabile, ma la mutazione che lui propone dovrebbe sconfiggere per lo meno l’individualismo e il narcisismo, fino a quel punto esaltati dalla società erotico-pubblicitaria. Egli è superiore a Bruno, spettatore passivo della vita consumistica occidentale, dove anche la sessualità e oggetto di reificazione, e lui si adegua. Contrariamente al fratellastro, Michel propone un cambiamento che ai suoi occhi potrebbe essere radicale. Vive con questo unico scopo, raggiunto il quale la sua vita diventa inutile. Divorato da un famelico vuoto interiore, lui è l’uomo che non riesce a sentire la propria emotività e che sa di essere il prodotto finale di un’autodistruzione a cui è destinata l’umanità intera se qualcuno non cambia il suo corso. Da biologo, in realtà scienziato-filosofo, considera lo spazio un aggregato mentale in cui può formarsi il tempo, e sconvolge la comunità scientifica considerando non più necessari sia l’ipotesi di una realtà latente che la stessa possibilità di Dio. Fiducioso nella meccanica quantistica, Michel sostituisce l’ontologia degli oggetti con un’ontologia di stati, l’unica che potrebbe restaurare i rapporti umani più veri. La fiducia che fraternità, simpatia e amore possano essere salvati dipende dall’identificazione tra le particelle elementari delle funzioni di onda e di conseguenza dei vettori di stato. Da ciò dipendono sia lo spazio che la natura, frutto di una creazione mentale. In questo ambito, nello spazio mentale dipendente dagli uomini possono formarsi sia l’unione, cioè la pratica del bene, che la separazione, cioè la pratica del male. Michel, in sintesi, se propone un nuovo ma incerto ideale di libertà individuale, cerca in compenso di ristabilire le condizioni di possibilità dell’amore. Annabelle è stata, se non la donna veramente amata, l’immagine stessa dell’amore, il conforto e lo sprone per i suoi studi.
I due fratellastri non sono dunque complementari come l’astuzia di Houellebecq, così abile nel nascondersi, ha tentato di farci credere. Le vicende legate a Bruno, per quanto importanti, sono funzionali alla comprensione del dramma di Michel, e forse rivelano la volontà un po’ furba dell’autore di creare scandalo con l’esibizione della sessualità. La provocazione, con ogni probabilità, ha finalità estrinseche al significato globale del libro. Al centro di tutto c’è Michel, Eroe della conoscenza scientifica, ma dalle idee forse non così salvifiche come sembrerebbe… Lo stacco temporale che separa l’Epilogo dal racconto precedente non solo proietta nel futuro il momento della narrazione collocando l’io oltre la prospettiva della contemporaneità, ma definendo ciò che segue “Storia” falsificare le vicende biografiche dei due fratellastri. Tutta la narrazione del romanzo si concentra nella clonazione del genere umano, resa necessaria dal disastro della nostra vita in società. Ma è davvero vicina e verosimile la mutazione genetica dell’intera umanità? O non si deve pensare piuttosto alle proposte scientifiche di Michel come a un paradosso, un’ipotesi inverosimile? Si tratterebbe di una salvezza davvero possibile? Di fondato c’è soltanto il senso di disperazione che promana dalle vite dei due fratellastri e dalla sofferenza personale di Michel, amante disperato dell’amore. A sorreggerlo non è tanto l’ingenua fiducia nelle virtù del positivismo scientifico, dove tutto è razionalizzabile, quanto l’esempio di Annabelle di un’emotività genuina e vitale. Tra l’altro, sia lei che Christiane hanno sacrificato la loro vita a beneficio dei due fratellastri (e a questo riguardo pare difficile continuare a dipingere Houellebecq come un misogino).
La denuncia della crisi della nostra società e dei suoi valori è comune alle opere successive di Houellebecq e non può essere messa in discussione. In «Le particelle elementari», sostanzialmente il suo esordio, immagina un’improbabile mutazione metafisica come prova della sua analisi spietata e disillusa dei rapporti umani: colloca in un futuro di fantasia la soluzione di un problema che lo assilla, il destino degli uomini, e ci mostra la miseria della condizione umana. La sua ironia si spinge a formulare un futuro prossimo di salvezza mediante la clonazione dell’umanità, un sogno che la voce narrante spaccia come “Storia” e che è invece la raggelante conclusione di un romanzo distopico. Il finale del libro può ingannare qualche lettore ingenuo in vena di facili speranze, ma il pessimismo dell’autore, che sfiora il nichilismo, è innegabile quanto lapidario. Nel romanzo c’è poco Comte o Circolo di Vienna, molto Schopenhauer o l’Huxley che aveva corretto radicalmente il suo “Mondo nuovo”, che nuovo non è agli occhi di Michel e di Houellebecq.
L’autore riesce ad addolcire il suo messaggio in vari modi, non solo con il ricorso al racconto dettagliato della complicata vita sessuale di Bruno. Lo fa mediante una variazione stilistica che va dalla fredda dimostrazione scientifica alla descrizione lirica di alcuni momenti cruciali in cui Michel e altri personaggi riflettono sui loro drammi personali a contatto con la natura. Inoltre, la mano dell’autore è evidente con l’alternanza dei punti di vista e i cambi di registro linguistico: la voce narrante, se racconta di Bruno (personaggio in sé e per sé detestabile), adopera il suo frasario volgare e gli epiteti più antifemministi e razzisti; se ci parla di Michel, fa ricorso al linguaggio settoriale della biologia e della fisica, rivolgendosi a un destinatario ben informato in materia. Ancora la volontà di Houellebecq di dissimulare sé stesso nella narrazione. E forse anche la conferma del suo disinteresse per il lettore, probabilmente disprezzato, nonché la capacità di cambiare volto alla propria scrittura.
E se il mondo hippy e New Age è messo così in cattiva luce, è legittimo rimanere nel dubbio se questo è il pensiero dell’autore, o no. Così come ci si potrebbe chiedere se in fondo Houellebecq non sia un critico del progresso, un nostalgico delle relazioni sociali del buon tempo andato. Motivi in più per approfondire l’esame di un autore che ha in ogni caso qualcosa da dirci. Soprattutto perché la sua vera intenzione è quella di studiare e capire l’uomo e ciò che lo aspetta. L’explicit non lascia dubbi, il libro è nonostante tutto un omaggio all’umanità:
Nel momento in cui i suoi [dell’uomo di oggi] ultimi rappresentanti sono sul punto di estinguersi, riteniamo dunque legittimo rendere all’umanità quest’ultimo omaggio; omaggio che, anch’esso, finirà cancellato e perso nelle sabbie del tempo; è tuttavia necessario che tale omaggio, una volta almeno, venga reso. Questo libro è dedicato all’uomo.