In Prometeo incatenato, Eschilo fa dire a Prometeo, come risposta all’invito di gridare il proprio racconto: «Il racconto è dolore, ma anche il silenzio è dolore». Non c’è da meravigliarsi se Lo Spasimo di Palermo riporti questa citazione all’inizio. Vincenzo Consolo è impietoso e non risparmia niente e nessuno: né la società, né il nostro Paese, né le contraddizioni di noi uomini.

Il libro, che deve il suo titolo all’omonimo dipinto di Raffaello Sanzio, è imperniato sulla figura di un uomo anziano, Gioacchino, che sta facendo i conti con tutti i fallimenti della sua vita. Non è riuscito a mantenere l’amore di suo figlio Mauro, rifugiato politico a Parigi in seguito agli «anni di piombo»; il loro incontro parigino, che apre il romanzo, conferma la reciproca freddezza, che non è solo pudore di sentimenti, ma incapacità di svelarsi di fronte a se stessi prima che all’altro. Il figlio ironizza sulla pretesa di Gioacchino di essere chiamato «padre»; i due si congedano per l’ultima volta senza aver sciolto i loro nodi. L’uomo ha smarrito anche l’amore della moglie Lucia, amore che si è perso nei gorghi della malattia mentale; una tragedia accaduta a tutti e due durante la seconda guerra mondiale ha sconvolto a lungo andare la mente della donna. Ora Lucia, irrecuperabile nella sua infermità, giace in un manicomio di Palermo. Gioacchino ha anche rinunciato alle sue ambizioni di scrittore, consapevole dell’inutilità di ogni messaggio e di ogni denuncia. È in procinto di tornare in Sicilia: ha dovuto riscontrare la crudele falsità delle lusinghe della moderna città industriale. Milano, la città un tempo asilo di speranza, lo ha tradito.
Ma il ritorno del reduce non è felice; cade ineluttabilmente anche l’idea di un ritorno pacificatore nel rifugio sicuro dei suoi avi. A Parigi ha rivisto un vecchio film di un giustiziere chiamato «Judex». che lo ossessionava perché non era riuscito a vederne il finale. Naturalmente la visione della pellicola, un feuilleton senza pretese, è stata una delusione e non ha certo fugato l’angoscia dell’uomo. Allo stesso modo, Palermo, fetido centro di potere e di ferocia, spegnerà ogni speranza residua di riscatto. Inoltre, si rivelerà fatale a lui e a un giudice che combatte per imporre la forza dello Stato sulla violenza mafiosa. Il romanzo si chiude tragicamente con l’assassinio del procuratore da parte della mafia; la sua morte coinvolge anche il protagonista.
In una lettera che Gioacchino scrive per il figlio, poco prima del drammatico finale, i nodi della vicenda vengono finalmente chiariti: la tragedia giovanile che ha condotto la moglie alla follia è stata una forma di parricidio involontario da cui Gioacchino ha saputo risollevarsi con l’oblio e con l’amore per la donna; al figlio non può rimproverare la consapevolezza di un comportamento inevitabile e simile al suo; il giustiziere del suo film sembra incarnarsi nel procuratore che abita di fronte a lui, con la differenza che questo finirà sconfitto.
Lo Spasimo, come detto, è un quadro di Raffaello che si ispira a una chiesa palermitana, da cui prende il nome, divenuta poi lazzeretto durante la peste. Per Consolo lo Spasimo, in questa doppia accezione, è l’emblema non solo di Palermo, ma di una situazione storica di violenza che si ripete nei secoli e di una condizione umana reietta, di esilio da se stessi. L’esilio è nella perdita, l’assenza, in noi l’oblio, la cieca indifferenza: queste parole, nel testo, esprimono meglio di tante altre il senso di abbandono di se stessi che nel protagonista trova un lucido e spietato interprete.
Consolo è uno dei pochi autori che hanno saputo coniugare coscienza civile e impegno intellettuale, rabbia da una parte e poesia dall’altra. Nello Spasimo di Palermo troviamo i drammi di Falcone e di Borsellino (quest’ultimo praticamente citato) uniti ai conflitti interiori dei personaggi, conflitti che riguardano e toccano noi tutti. L’autore ha avuto la rara capacità di fondere insieme i drammi personali, come il rapporto padre-figlio, la debolezza della ragione umana, l’amore, con i problemi della società e della Storia; da una parte il dolore di un esilio che l’uomo ritrova in se stesso, dall’altra la sofferenza e la rabbia di chi trova calpestati e irrisi gli ideali più elementari di giustizia. Per arrivare a questo risultato Consolo ha dovuto elaborare una fitta trama di relazioni fra i personaggi e tra diverse epoche. Nella prima parte del testo si rifà all’alternanza tra presente e passato, con frequenti analessi; nella seconda non ci sono cambiamenti di luogo o di tempo notevoli (l’azione si svolge a Palermo in maniera lineare fino al tragico epilogo). Ne risultano quasi due modi diversi di raccontare, ma questo non può essere considerato un difetto, giacché la vera unità del romanzo, al di là della continuità della vicenda, è data dal mezzo espressivo, una lingua che non rinuncia ai preziosismi tipici dell’autore e ad una efficacia lontana da ogni realismo.
Consolo non ha rimedi o soluzioni per i lettori, gli basta narrare e far capire la tragedia dell’uomo, il suo calvario. Suo portavoce nel romanzo è il vecchio fioraio che assiste all’attentato dinamitardo al giudice e che nelle ultime due righe del libro implora muto: O gran mano di Dio, ca tantu pisi, / cala, manu di Diu, fatti palisi!
Da leggere:

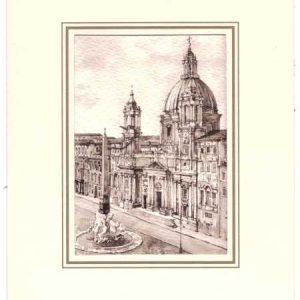

Caro Vittorio, tanto apprendo dalle tue interessantissime recensioni; non sempre commento… di certo le leggo. Grazie di cuore
Giuseppe
"Mi piace""Mi piace"
Grazie a te per il tuo interesse.
"Mi piace""Mi piace"